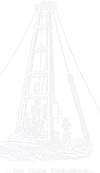L’articolo va fornito su file, come documento di testo Word, Garamond, 12 pt, giustificato, interlinea 1, seguendo lo schema e le specifiche illustrati di seguito, utilizzando il template allegato come modello di testo per quanto attiene carattere, titoli e note.
Titolo [lunghezza massima di 150 battute]
Titolo in inglese [lunghezza massima di 150 battute]
Nomi Cognomi degli Autori
Abstract
Abstract in inglese
L’abstract deve avere una lunghezza massima di 800 battute per ciascuna lingua; le traduzioni sono a cura degli Autori.
Introduzione [eventuale, non numerata; l’articolo può anche iniziare con alcuni paragrafi introduttivi privi del titoletto Introduzione]
1.Titolo dei paragrafi [numerati, tondo grassetto]
1.1 Titolo dei sottoparagrafi [numerati, corsivo grassetto]
Il contributo nel suo insieme deve avere una lunghezza massima di 25.000 battute (spazi inclusi), escluse note o bibliografia, che devono avere una lunghezza massima pari a circa il 20% del testo (nel caso di testo di 25.000 battute, note di 5.000 battute). Il testo potrà essere redatto in italiano o in inglese. È responsabilità degli autori la qualità delle competenze linguistiche.
Le note sono da inserire nel testo tramite l’apposito comando di Word come note a piè di pagina[1]. La nota deve essere posizionata dopo la parola ma prima della punteggiatura.
Una bibliografia finale è prevista solo nel caso in cui il testo, a carattere fortemente sintetico e tecnico, non preveda note a piè di pagina, ma una bibliografia di riferimento complessiva.
Si devono evitare parole sottolineate, in grassetto, MAIUSCOLE, riconducendo al corsivo e alle virgolette, doppie (“…”) per la forzatura nell’uso di un termine o caporali («…») per le citazioni (che vanno in tondo, non in corsivo).
All’interno del testo, i richiami alle immagini vanno chiaramente collocati in ordine progressivo e univoco rispetto all’andamento dell’articolo (ad es.: Figura 1, Figura 2, Tabella 1, Figura 3, Tabella 2 ecc.).
Le immagini non vanno inserite nel testo ma devono essere fornite su file separati (.jpeg, con risoluzione minima 300 dpi); le tabelle possono essere realizzate in Word o in Excel, anche all’interno del testo. Figure e tabelle devono essere nominate in maniera chiara in riferimento ai richiami del testo. Si suggerisce di verificare la leggibilità delle immagini a colori anche nel caso di riproduzione in bianco e nero.
Tutte le immagini, ove necessario, dovranno essere corredate dalle opportune autorizzazioni alla pubblicazione.
Le immagini di corredo al testo dovranno rientrare nel limite di pagine previsto per ogni articolo (ogni pagina di immagini corrisponde a circa 4500 caratteri di testo). Ove gli apparati illustrativi (foto, grafici, disegni, tabelle) abbiano un ruolo predominante rispetto al testo, gli autori devono tenere conto della griglia di impaginazione della Rivista: gli apparati devono essere leggibili e le dimensioni complessive, testo e note compresi, non devono comunque eccedere quelle indicate (dopo l’accettazione della proposta eventuali esigenze particolari potranno comunque essere valutate con la Redazione caso per caso, come l’interdisciplinarità della Rivista richiede).
Le didascalie delle immagini e delle tabelle vanno fornite in un file di testo a parte, e messe in relazione in maniera univoca con le rispettive immagini:
Figura 1: Didascalia dell’immagine (Garamond, 12 pt, giustificato, interlinea 1, corsivo).
Dove necessario, le didascalie devono inoltre contenere tutti i dati relativi agli autori e agli eventuali aventi diritti.
Citazioni bibliografiche in nota [vedi sopra]
Le convenzioni da adottare sono le seguenti:
Per i volumi:
- autore: nome proprio per esteso e cognome; se si tratta del curatore di un volume aggiungere (a cura di) dopo il cognome; nel caso di autori vari, omettere l’indicazione
- titolo: di volume, di articolo in volume: in corsivo;
- casa editrice;
- luogo di pubblicazione (se straniero, in lingua originale);
- anno di pubblicazione;
- pagina o pagine (p. o pp.) cui si fa riferimento;
- il numero dei volumi è indicato subito dopo il titolo.
Tutte le voci, eccetto nome-cognome autore (ed eventuale a cura di) e data, devono essere separate da una virgola, come esempi che seguono.
Vera Comoli Mandracci, Torino, Laterza, Roma-Bari 1983 (ed. consultata 2006).
Vera Comoli, Carlo Olmo (a cura di), Torino. Guida di architettura, Allemandi, Torino 1999.
26 itinerari di architettura a Torino, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Torino 2000.
Agostino Magnaghi, Mariolina Monge, Luciano Re (a cura di), Guida all’architettura moderna di Torino, Designers Riuniti Editori, Torino 1982 (ed. consultata Celid, Torino 2005).
Guido Montanari, Andrea Bruno jr, Architettura e città nel Novecento. I movimenti i protagonisti, Carocci, Roma 2009.
Per i cataloghi di mostra:
Fulvio Ferrari, Napoleone Ferrari (a cura di), Carlo Mollino. Arabeschi, catalogo della mostra (Torino e Rivoli, 20 settembre 2006 – 7 gennaio 2007), Electa, Milano 2006.
Per atti di convegno (seminario, …) indicare anche luogo e data del convegno:
Maria Rosa Masoero, Sergio Mamino, Claudio Rosso (a cura di), Politica e cultura nell’età di Carlo Emanuele I. Torino, Parigi, Madrid, atti del convegno internazionale di studi (Torino, 21-24 febbraio 1995), Olschki, Firenze 1999.
Per i capitoli o saggi in un volume collettivo:
- autore: nome proprio per esteso e cognome; se si tratta del curatore di un volume aggiungere (a cura di) dopo il cognome;
- titolo: di volume, di articolo in volume: in corsivo;
- luogo di pubblicazione (se straniero, in lingua originale);
- casa editrice;
- anno di pubblicazione;
- pagina o pagine (p. o pp.) di inizio e fine dell’articolo;
- il numero dei volumi, il volume (vol.), il libro sono indicati subito dopo il titolo.
Tutte le voci, eccetto nome-cognome autore (ed eventuale a cura di) e data, devono essere separate da una virgola, come esempi che seguono.
Costanza Roggero Bardelli, Vigna del Cardinal Maurizio di Savoia, in Costanza Roggero Bardelli, Maria Grazia Vinardi, Vittorio Defabiani, Ville sabaude, Rusconi, Milano 1990, pp. 172-199.
Vera Comoli Mandracci, L’urbanistica della città capitale e del territorio, in Giuseppe Ricuperati (a cura di), Storia di Torino. IV. La città fra crisi e ripresa (1630-1730), Einaudi, Torino 2002, pp. 431-461.
Andrea Longhi, Le strutture insediative: dalle geometrie di impianto alle trasformazioni dei paesaggi costruiti, in Rinaldo Comba, Andrea Longhi, Riccardo Rao (a cura di), Borghi nuovi. Paesaggi urbani del Piemonte sud-occidentale. XIII-XV secolo, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 2015, pp. 29-68.
Per gli articoli di rivista:
- autore: nome proprio per esteso e cognome in maiuscoletto;
- titolo dell’articolo: in corsivo;
- titolo del periodico (quotidiano, annuario, …) per esteso, sempre tra virgolette « »;
- volume in numeri romani o arabi;
- annata o fascicolo, se la rivista è numerata per fascicoli anziché per anni, in numeri arabi;
- anno;
- pagina o pagine (p. o pp.) di inizio e fine dell’articolo.
Tutte le voci, eccetto nome-cognome autore (ed eventuale a cura di) e data, devono essere separate da una virgola, come esempi che seguono.
Roberto Gabetti, Giorgio Raineri, Ina-Casa a Orbassano, in «Casabella Continuità», n. 212, settembre-ottobre 1956, pp. 34-35.
Roberto Gabetti, Per Carlo Mollino, in «Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino», n. XXXIX-1 n.s., gennaio 1985, pp. 17-22.
Paolo Cornaglia, Il Palazzo Reale di Torino in epoca napoleonica: disegni e progetti dagli archivi parigini, in «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», XLIX n.s., 1997, pp. 177-184.
Andrea Longhi, Fonti contabili per lo studio dei cantieri ecclesiastici subalpini nel basso Medioevo, in «Studi Piemontesi», vol. XLII, fasc. 1, 2013, pp. 209-216.
Per le tesi di dottorato e di laurea:
Mastro Geppetto, La fabbricazione dei burattini, tesi di laurea magistrale in Architettura Costruzione Città [e non la materia specifica, ovviamente], Politecnico di Torino, relatore Mastro Ciliegia, a.a. 2019-2020 (o in alcuni casi ormai le datano in modo specifico, febbraio 2020)
Mastro Ciliegia, Il problema dell’allungamento dei nasi dei burattini, tesi di dottorato di ricerca in Beni architettonici e paesaggistici, Politecnico di Torino, XXIII ciclo (2020), tutor Il Grillo Parlante.
Citazioni ripetute
Nel caso si debba citare nuovamente un’opera già citata, si indica il cognome dell’autore, il titolo dell’opera abbreviato seguito da cit. (quest’ultimo in tondo e non preceduto da virgola). Non usare mai op. cit.
Ibid. si usa per indicare un’opera citata alla nota immediatamente precedente.
Id. si usa per indicare un autore citato alla nota immediatamente precedente.
1 Italo Calvino, I libri degli altri, Einaudi, Torino 1991, p. 371.
2 Calvino, I libri cit., p. 268.
3 Id., La giornata d’uno scrutatore, Einaudi, Torino 1963, p. 61.
4 Ibid., p. 67.
Citazione dei documenti di archivio
Manoscritti, disegni, carte e, in generale, i documenti conservati in archivio dovranno essere indicati in modo dettagliato, indicando l’istituzione archivistica conservatrice, il fondo archivistico e tutti gli estremi necessari per l’individuazione univoca della fonte.
Qualifiche degli Autori [dell’articolo; corsivo, 2 righe]
Fornire l’affiliazione ufficiale di tipo universitario, amministrativo o professionale, con eventuali brevi note aggiuntive se necessarie a specificare a quale titolo si affronta il tema proposto sui modelli seguenti:
Pico De Paperis, professore associato di Tuttologia applicata, Università di Paperopoli.
pico.depaperis@unipap.edu.
Lisa Simpson, professoressa ordinaria di Storia, Politecnico di Springfield
simpson.lisa@polispring.edu
Personale strutturato: l’essere professore o ricercatore oscura il fatto di essere dottore di ricerca e specialista.
Nome Cognome, arruolamento [minuscolo] di Settore disciplinare [maiuscola la prima], Università/Ente d’appartenenza, Dipartimento, indicare eventuali altri incarichi direzionali (riviste, associazioni, reti ecc.), direttore di qualcosa (Scuola, dipartimento ecc.), o essere membri significativi di qualcosa se rilevante (FULL, R3C se c’entrano, non a priori).
Evitare: “si occupa di…” a meno che non sia funzionale al contributo.
Arruolamenti previsti [tutti minuscoli]:
professore ordinario
professore associato
ricercatore universitario
ricercatore a tempo determinato
Personale universitario non strutturato, assegnisti non dottorandi ecc.
Wilma Flintstone, laureato magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale [solo la prima maiuscola], assegnista di ricerca presso il Politecnico di Torino, DIST
Roger Rabbit, dottore di ricerca in Beni architettonici e paesaggistici, assegnista di ricerca presso il Politecnico di Torino, Responsible Risk Resilience Centre
[assegnisti senza dottorato indicare la laurea, assegnisti con dottorato prevale il dottorato e si omette la laurea; non indicare la disciplina]
Dottorandi
Fred Flintstone, dottoranda in Urban and regional development, [solo la prima iniziale maiuscola, Politecnico di Torino [non indicare il dipartimento]
Laureati, specialisti e dottori di ricerca in stand-by
Marge Bouvier, laureata magistrale in Architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio [tutto minuscolo salvo l’iniziale] presso il Politecnico di Torino
Winnie the Pooh, specialista in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Genova
[se non è più l’arruolamento attuale, indicare “presso”]
[1] Corpo delle note (Garamond 10 pt).